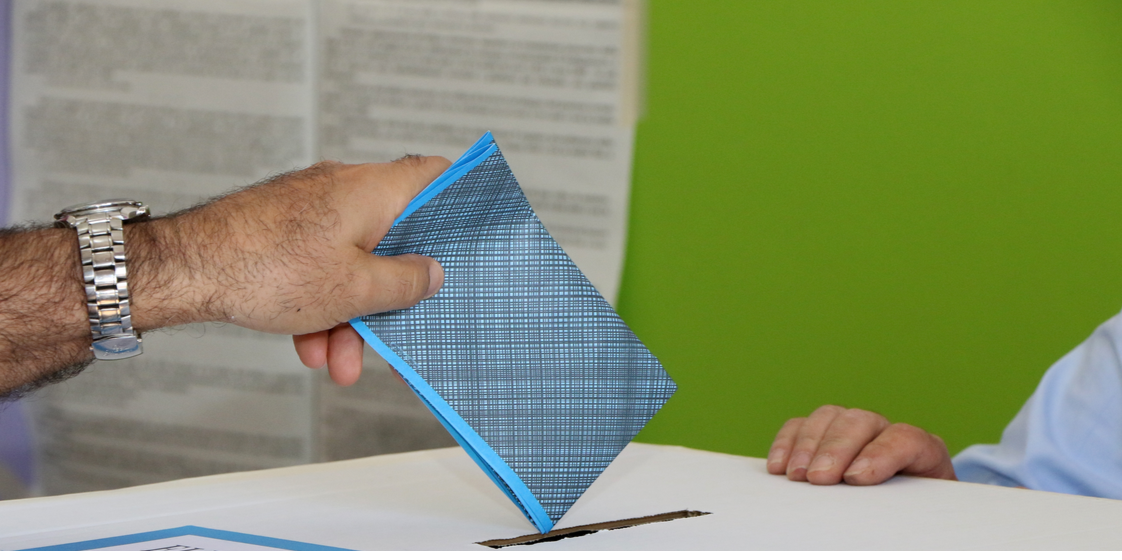I padri costituenti avevano inserito nella nostra Carta fondamentale l’istituto referendario solo in forma abrogativa, ponendo tuttavia alcuni vincoli. In primo luogo avevano escluso la possibilità che si potessero tenere referendum in materia di leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto e autorizzazione a ratificare trattati internazionali: in tal modo questioni che andavano a toccare il benessere e la libertà dei cittadini e gli impegni che il nostro Paese si sarebbe assunto a livello internazionale sarebbero state devolute, saggiamente, all’esclusiva discrezionalità del Parlamento e del Governo, ferma restando la possibilità dei cittadini, se insoddisfatti, di cambiare l’uno e l’altro al successivo passaggio elettorale.
Il secondo vincolo era che il referendum avrebbe prodotto effetti solo se ad esso avesse partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto: un vincolo puramente teorico in un’epoca in cui la partecipazione al voto a tutti i livelli era assai alta, come testimonianza della fiducia dei cittadini nella riconquistata democrazia.
In tutta evidenza i costituenti pensavano che il referendum avrebbe potuto servire solo come estrema verifica della corrispondenza fra taluni atti legislativi ed il sentire popolare: non a caso, per i primi venticinque anni della storia repubblicana le forze politiche nemmeno pensarono di approvare una legge che regolasse l’istituto referendario poiché esse, sia alla maggioranza che all’opposizione, ritenevano che sarebbe spettato alla dialettica politica determinare gli indirizzi legislativi.
Non a caso, il primo referendum si svolse nel 1974 su di una questione oggettivamente lacerante per la coscienza nazionale come quella del divorzio, e comunque fino all’ultimo i partiti politici, qualunque fosse il loro orientamento, cercarono di trovare una mediazione che impedisse la celebrazione del referendum.
Con il passare del tempo i referendum si sono moltiplicati, particolarmente ad iniziativa di una forza politica strutturalmente minoritaria come il Partito Radicale, che attraverso la mobilitazione sui quesiti referendari puntava a sottolineare la discrasia fra l’immobilismo dei partiti tradizionali, e per conseguenza del Parlamento, e la coscienza civile dell’opinione pubblica che si riteneva più avanzata.
Del resto, anche le ACLI, sotto la guida di Giovanni Bianchi – di cui stiamo per ricordare il quinto anniversario della sua scomparsa-, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso accettarono il principio dell’uso del referendum come stimolo all’azione parlamentare su di una questione essenziale come quella della riforma elettorale, su cui era in atto da anni un braccio di ferro inconclusivo fra le diverse forze politiche.
Tuttavia, la previsione costituzionale della validità del referendum solo col raggiungimento del quorum, combinandosi con la crescente disaffezione al voto (che si è vista anche domenica scorsa, sebbene ovviamente i votanti alle elezioni amministrative siano stati percentualmente più di quelli per i referendum), rappresenta un crescente elemento di fragilità dello strumento referendario spingendo le forze politiche contrarie ai quesiti proposti ad assecondare le tendenze astensionistiche piuttosto che ad affrontare a viso aperto la battaglia per il No.
Il fallimento dei referendum del 12 giugno è figlio di questa situazione, cui si è aggiunta la condotta a dir poco singolare di alcuni dei promotori, ad esempio la Lega, che ha mobilitato cinque Consigli regionali perché si facessero promotori dei quesiti senza passare per la raccolta delle firme (e sarebbe anche interessante capire per quale motivo le Regioni avrebbero dovuto occuparsi di certe questioni) e ha poi rinunciato a fare campagna elettorale, avendo previsto l’esito negativo.
Il problema non sta nell’eccesso di tecnicismo dei quesiti: non è che quelli in materia di legge elettorale o di beni comuni fossero più chiari. Semplicemente, chi promosse quei referendum fu capace di mobilitarvi attorno un interesse reale, anche grazie agli autogol degli avversari (ad esempio il famoso “andate al mare” di Bettino Craxi), mentre i promotori dei cinque referendum sulla giustizia non ci hanno nemmeno provato.
Certo, c’è un problema specifico che riguarda l’istituto referendario, ma non si può non vedere come la questione di fondo rimanga quella del calo della fiducia nelle istituzioni, come testimoniato dall’affluenza poco più alta per le elezioni amministrative: e non è solo un problema italiano, se è vero che solo la metà dei cittadini francesi ha ritenuto di scomodarsi ad andare a votare per le elezioni parlamentari.
E non c’entra neppure la paura della pandemia, visto che la circolazione del virus non impedisce che le spiagge e le città d’arte si riempiano di nuovo (e finalmente) di turisti e che concerti e partite di calcio facciano registrare regolarmente il sold out.
Più semplicemente – e desolantemente – sembra essere venuta meno la fiducia nel fatto che gli istituti della democrazia possano effettivamente cambiare la vita delle persone, e questa sfiducia si allarga a tutti i soggetti che in qualche modo sono legati alle istituzioni stesse, ivi compreso l’ordine giudiziario, ma anche i sindacati, l’associazionismo istituzionale, la stessa Chiesa.
Molto spesso si è parlato di questo malessere democratico, ma ben poco si è fatto per andare oltre la semplice enunciazione del problema: il rischio reale è quello di andare verso una crescente erosione dei fondamenti stessi della democrazia aprendo la strada a pericolose avventure.
Forse sarebbe ora di guardare in faccia questo problema e trovare una risposta seria e concreta.
Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli